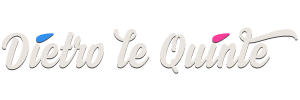Fiamme di dolore gli involucrano tutti i pensieri, anche quelli più beduini. Mario è un sudario moribondo di bende morte che respira grazie all’aiuto artificiale di una macchina che zampilla elettronici squittii ogni cinque secondi. Lui è qui, abissato in questo giallo letto d’ospedale; anche io sono qui e conto le piastrelle del pavimento con la circospetta zelanteria di un archivista precario. «Sono qui», vorrei sussurrare dolcemente a quel che resta del suo padiglione auricolare destro e invece tutto quello che faccio è chiedere dove è il cesso alla caucasica infermeria di occidentale fard agghindata. Fosse uno dei suoi fottuti film adesso il tizio con gli spuntoni in faccia straccerebbe questa stanza facendo dei suoi incubi sogni da metallaro rissoso. Mentre aspetto la risposta della non svelta esponente del servizio sanitario nazionale lingue di tende leccano il vuoto con malcelata cupidigia.
Stacey fa: «In fondo al corridoio, a destra».
Il suo cartellino non dice Stacey naturalmente, anche perché non ne ha uno, ma lei per me è Stacey ed è colpa di tutto il mio immaginario cinematografico yankee se un cazzo di crocerossina ha un nome del tipo: «Hey baby, io sono l’Ammerica e tu sei solo mondo».
Ma
Mario
mangia
mandarini
marci
gli ho scritto ieri notte sulla porta della stanza. Se si sveglierà saprà che con questa allitterazione anaforica ho inteso sottolineare la sua indecisione esistenziale, perché lui tra tante vie sbagliate da percorrere ha sempre scelto di balbettare. Ed è anche per questo che oggi si trova mummificato a rantolare raucamente e cercando a tutti i costi di morire male, ovvero nella maniera più schifosa possibile. Sondo con il mio occhio verde vomito tra le pieghe delle sue bende e vedo che vuole recidere dalla sua umanità: fosse per lui sarebbe già sangue evaporato dalla guancia del suo assassino. Non agogna nemmeno la tomba, il moribondo. «Il massimo che puoi chiedere a dei sepolcri è di essere scritti da Foscolo», scriveva appena tre giorni fa con la sua stupida ironia.
Facevamo a gara come due ragazzetti per chi avesse più talento letterario e io, a dirla tutta, penso di averne avuto sempre più di lui, anche perché con uno che fa affidamento sui soliti quattro verbi (fissare, scavare, credere, guardare) per “atmosfereggiare” la sua poetica non è che ci voglia molto a primeggiare. Questo rimasuglio di carne che sta per chiudere il suo breve ciclo vitale ha il difetto di tutti i pavidi imbrattatori di carte: scrive solo su quello che sa e, dato che, come tutti, quello che sa è pochissimo, sporca malamente fogli spuri di quaderno. Aveva del sentimento ma lo teneva tutto racchiuso nel suo pugno all’interno del petto, convinto che solo una manciata di eletti fosse in grado di vedere quel prisma di affetto. Adesso che è diventato spazzatura umana da raccattare al massimo dopo questa lurida nottata, lo vedo per quello che è sempre stato: un coglione da compiangere.
«Ma lei non doveva andare in bagno?», mi chiede Donna con la sua voce da pulisci-culo petulante.
«Ho cambiato parrucchiere», le rispondo con un nonsense che farebbe felice il ragazzo che spompinavo appena tre giorni fa mentre scriveva cazzate pseudo-sardoniche su Foscolo e che, toh, è lo stesso tizio fasciato di bianco che respira i suoi ultimi strazi sul letto di fronte a me. Raccolgo le dita come se volessi afferrare un pezzo d’aria, le muovo tre volte avanti e indietro e, magia della codificata gestualità occidentale, Patricia ciabatta via come facevo io ogni volta che lo lasciavo steso sfinito sul letto con la mia celeberrima ars amatoria tramandata dalle più impudiche concubine francesi.
Davvero, era facile sorprenderlo. Lasciavo sul comodino una copia de I Buddenbrook e lui subito rinnovava le sue fallaci promesse di uscire dalla depressione. Io, dal canto mio, gli volevo bene come si può volerne a una sigaretta rollata ottimamente dalla tua migliore amica e trovata fortuitamente sul tavolo della cucina dopo una nottata alcolica. Da anni non riuscivamo più a condividere senza sofferenza quello che era stato il nostro talamo peccaminoso e solo la letteratura fatta male ci univa ancora. In fondo però… Lo guardo, lo fisso e credo che si fosse già scavato un buco di misantropia da tempo.
Qualche lacrima dopo
Sei sempre stato un sempliciotto: nelle nostre notti di vino rotto volevi lavarmi il cuore con abluzioni di sperma, in presenza di un’assenza finta posponevi virgole o responsabilità e mentre il tuo desiderio di vita scuffiava spetazzavi tutto lo spezzettabile umano in conati sordi di volgare malinconia. Per te un neonato che strilla la sua fame era un segno del tempo che passa inesorabile, ascoltavi l’ultimo album dell’ultima band che ha venduto il proprio talento progressive per cullarti nella consapevolezza che tutto può essere annientato e che niente resiste, niente vince perché il concetto di vittoria è un concetto umano e non basta saperlo per essere un genio.
Immaginazione e realtà sono sbarre della stessa prigione di spazio fratto tempo diviso due col resto che non sai dove mettere, dimmelo tu Mario dove, mi chiedevi di fidarti del tuo dolore ma ora che stai per diventare Nulla ho bisogno di te, ora che stai per morire dimenticato come sei sempre stato in vita ho bisogno di te, della tua inconcludenza, della tua infelicità, della tua inabilità, della tua ingestibilità, della tua devianza che fa di te stesso me stessa e cioè un personaggio letterario da cui vuoi farti rimpiangere ancora una volta, appunto.