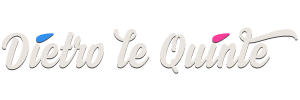Nella ricca stagione del Teatro Quirino di Roma dal 4 al 9 aprile è andato in scena Il signor Pùntila e il suo servo Matti, una delle più famose e fortunate commedie di Bertolt Brecht. Curatrice dell’allestimento è stata la milanese compagnia del Teatro dell’Elfo, fondata tra gli altri dal regista cinematografico Gabriele Salvatores, che sotto l’egida della collaudata coppia di autori Ferdinando Bruni e Francesco Frongia ha fornito al nutrito pubblico romano una rilettura ossequiosa del testo oramai classico del grande drammaturgo tedesco.

Abbiamo scritto rilettura ossequiosa perché siamo di fronte ad un testo che, scaturito da un’altra epoca, e cioè gli anni antecedenti la Seconda guerra mondiale, ma apparso sui palcoscenici soltanto dopo la fine del conflitto, ha finito per assumere coloriture ideologiche multiple che l’hanno connotato temporalmente fino a farlo diventare inevitabilmente, vuoi anche per il noto marxismo di Brecht, un prodotto culturale poco empatico a un pubblico che sta vivendo in pieno l’ascesa di un populismo avvinto alle sue fake news. Nonostante l’odierno disimpegno dalla res publica c’era da prendere posizione critica di fronte a un testo che la pretende. Il signor Pùntila e il suo servo Matti, dietro l’apparente bonomia della cifra comica da cui è percosso, mantiene infatti saldi i suoi assunti di base: il capitalismo moderno è incoercibilmente corrotto e la divisione in classi prive dell’utopistico ascensore sociale ne è conseguenza inderogabile.

I due registi Bruni e Frongia affrontano con sicurezza l’originale brechtiano scegliendo di tradurlo quasi letteralmente a partire dalla notevole durata dell’opera, due ore e quaranta piene. Nessuna delle dodici scene viene espunta o ridotta, facendo della reiterazione dei temi e delle battute un proprio punto di forza. Per soprammercato, invece di tagliuzzare personaggi o situazioni, la compagnia del Teatro dell’Elfo esaspera il lato farsesco dell’opera con accorgimenti comici perfetti nella loro collaudata tradizione. Ci riferiamo ad esempio all’uso di una certa gestualità slapstick, alla recitazione enfatica dei comprimari (il promesso sposo interpretato dall’”elfo d’adozione” Umberto Petranca è di una soave deficienza), al mantenimento della coralità dei personaggi che fa sì l’opera non scivoli in un one man show pùntiliano.

A proposito di quest’ultima notazione, bisogna plaudere ulteriormente a Ferdinando Bruni che oltre a tradurre e dirigere questa versione de Il signor Pùntila e il suo servo Matti interpreta proprio il protagonista. L’enorme carisma di un personaggio caratterizzato da alcolica bipolarità rischiava insomma di venir ulteriormente acuito dal centralismo autoriale di Bruni. Il regista e attore lombardo, invece, pur non rinunciando a un’importante presenza in scena (notevole l’uso che fa della voce, a ricoprire toni e semitoni sentimentali assenti in altre versioni e nello stesso testo originale), si avvale, come detto, di una compagnia che sa prendersi con merito i suoi assolo recitativi. Segnaliamo su tutti la brava Elena Russo Arman che nella seconda metà dell’opera, quella più prettamente comica, domina con la sua vezzosità da donna meneghina/hollywoodiana a più riprese il palcoscenico.

L’unico rimbrotto che si può opporre all’inevitabile modernismo di questa rilettura è che spacca in due il testo facendo smarrire nell’ultima ora la carsica critica sociale per un innocuo sarcasmo situazionale. Il servo Matti, interpretato da un Luciano Scarpa fin troppo controllato, si accontenta allora di redarguire la sua spasimante riguardo le difficoltà di una donna sposata a un operaio, facendo quasi delle differenze di classe una questione di costume. Si ride, certo, anche a crepapelle ma senza prender coscienza delle iniquità di un sistema che non è inevitabile, come i soloni dell’economia vogliono farci credere. Un peccato comunque veniale, in un’opera che ha il merito di insegnare qualcosa senza essere volutamente didattica o epica.