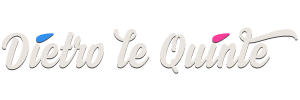Nella cupola della distopica Romdo il Cogito è un virus che inopinatamente comincia ad infettare gli AutoReiv (androidi dalle fattezze antropomorfiche) facendogli provare sensazioni ed emozioni e destabilizzando in questo modo la gelida perfezione di un mondo connotato con una chiara estetica cyberpunk. Dato questo assunto di base, l’anime Ergo Proxy, creato dagli studi giapponesi Manglobe e Geneon Entertainment nel 2006, suggerisce che anche gli umani sono tacciabili della stessa malattia, il pensiero razionale.
Basterebbe questo incipit di folgorante metaforizzazione per rendere manifesta l’ambizione di una serie che punta da subito ad addentrarsi nella trattazione di tematiche alte. La sceneggiatura di Ergo Proxy porta inoltre la firma di Dai Satō, nome di punta nel mondo anime che ha contribuito a riconosciuti capolavori di genere quali Cowboy Bebop e Kyashan – La rinascita. C’erano insomma tutti i presupposti e il giusto numero di puntate (23, una in meno di ogni serie breve che si rispetti) per la riuscita di un prodotto in un segmento quale l’animazione giapponese che ultimamente sta lentamente declinando verso una commercializzazione troppo orientata all’export della maggior parte delle sue produzioni. In Ergo Proxy, almeno nelle premesse, il rapporto con l’Occidente non era esclusivamente fondato sul marketing (anche se aver disegnato la protagonista sulle fattezze di Amy Lee, vocalist della band Evanescence, contribuiva ad alimentarlo supinamente) bensì sulla rilettura di alcuni generi preponderanti nel nostro immaginario culturale: la fantascienza, il noir, la letteratura odeporica.
A un plot di stampo marcatamente anglofono Ergo Proxy provava a miscelare il gusto tutto nipponico dell’introspezione psicologica e di un certo grado di alleggerimento kawaii. Se per quanto riguarda la prima sperimentazione possiamo parlare di un modesto clone del seminale Neon Genesis Evangelion (le tre puntate sui rispettivi tormenti dei tre protagonisti arrivano a serie quasi ultimata e tolgono interesse piuttosto che aggiungerlo) per quanto riguarda la seconda si giunge, purtroppo inevitabilmente, alla pecca ostativa che impedisce spesso la fruizione nel nostro Paese degli anime giapponesi.
Il personaggio della piccola robot Pino, con le sue smancerie e le sue irritanti petulanze da apprendista bambina, è totalmente scollato dal tono funereo della serie (nota a margine: gli sfondi sono renderizzati in un 3D talmente approssimativo da rasentare l’amatorialità e, anche considerando la cupezza degli eventi, non sono giustificabili). Il tema dell’innocenza dello sguardo, peraltro meccanico e quantificabile aritmeticamente da un numero esiguo di bit, in un mondo asetticamente evoluto avrebbe meritato uno sviluppo più maturo piuttosto che la solita sequela di gag pucciose.
Una mancata presa di distanza autoriale che Dai Satō non ha il coraggio di imporre alla serie anche in un altro paio di occasioni. Innanzitutto il celebre sceneggiatore giapponese non rinuncia alla puntata riassuntiva degli eventi occorsi in precedenza, suo venefico marchio di fabbrica. Questa volta, rispetto ad altri suoi lavori, si serve di un espediente leggermente più accattivante e cioè un quiz-show che, oltre a ricordare agli spettatori stanchi i motivi del viaggio di Vincent, Re-I e Pino, slabbra con apparente noncuranza l’ordito della storia sia in senso orizzontale che in senso verticale.
L’altra occasione mancata la ritroviamo in un certo indecisionismo artistico che fa oscillare la serie fra una prima parte canonica (la peggiore: personaggi di contorno sciatti, prevedibilità narrativa e colpi di scena disegnati da un pilota automatico) e una seconda più concettuale e ardita.
Le ultime cinque puntate, infatti, abbandonano, senza colpo ferire, alcuni dei quesiti filosofici suggeriti precedentemente per concentrarsi sui dilemmi etici della divinità proxy che vive un’impasse amletica. La conseguenza di quest’ultima svolta tematica è la perdita definitiva della residua empatia dello spettatore che difficilmente potrà condividere le sofferenze di un Creatore senza memoria e in balia emozionale di una copia alata (ahimè, succede anche questo) della ragazza amata. E così Ergo Proxy, nonostante provi a indorare ulteriormente la sua confezione cibernetica con l’uso di una canzone “manifesto” come Paranoid Android dei Radiohead (gentilmente concessa dal gruppo inglese come sigla di chiusura), si rivela essere in nuce un’esplorazione psicologica dell’anima di Dio. Interessante se hai intenzione di dare la vita a qualche pianeta, meno se in un pianeta già ci vivi da mortale.