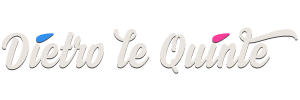Miike. Takashi Miike. Ripetilo. Ancora una volta. Fanne la tua nenia cinematografica anche quando scegli, raro caso, di buttarti nel tracotante mondo delle serie TV la cui superiorità sul cinema di genere è stata sancita da critici che di film ne avranno visti al massimo un centinaio. A costo di apparire berlusconiani l’escursione nel piccolo schermo è quasi sempre (solo il nuovo Twin Peaks promette bene come Yao Ming, il giocatore di basket cinese alto due metri e trenta che alla nascita misurava già 60-70 centimetri) una discesa o, quando va bene, un tentativo sperimentale di stilemi che matureranno o sono maturati con migliore e più libera forza su grande schermo.
Quest’ultimo caso è ad esempio riferibile alla serie oggetto di questa recensione: MPD Psycho (2000) di Takashi Miike. Il regista giapponese, sempre attento alle attrazioni (leggi soldi) della televisione e ai tempi stretti della realizzazione che in lui probabilmente stimolano particolari connessioni neurali a livello artistico, si lancia con la sua consueta prodigalità in questa trasposizione seriale del manga omonimo scritto da Eiji Ootsuka e disegnato da Shōu Tajima nel 1997. Ai tempi della produzione televisiva il fumetto era ancora ben lungi dal completo dispiegamento del suo arco narrativo, così Miike, che firma anche la sceneggiatura, mantiene intatto solo lo spunto di partenza sfrondandolo, in particolar modo, del suo ampio parco di personaggi. La storia della serie, divisa in sole sei puntate dalla durata circa di un’ora ciascuna, verte principalmente sulla triade di personalità distinte che contraddistinguono l’unico protagonista.
MPD Psycho dal punto di vista della narrazione procede abbastanza canonicamente in senso sia orizzontale che verticale: ogni puntata è autoconclusiva, ma contemporaneamente, pezzo per pezzo, porta avanti l’intricata indagine di Kazuhiko Amamiya fino al finale sospeso che, oltre a rappresentare una scelta stilistica chiara, conferma, semmai ce ne fosse bisogno, la dose di dozzinalità di Miike foriera a volte di tanto estro (mi riferisco naturalmente al celebre finale di Dead or Alive). Ma se una certa frettolosità si nota in particolar modo nell’ultima puntata piena di doverosi riassunti verbali recitati dall’atono Naoki Hosaka le farraginosità narrative di una vicenda confusa sin dalla sua ideazione non inficiano sulla resa estetica di MPD Psycho.
Il regista di Audition, infatti, gioca anche qui con diversi tabù sia cinematografici che sociali. Innanzitutto, dal punto di vista tecnico, la serie è tutta girata in digitale, ma, invece di puntare sui vantaggi di una modalità di ripresa veloce e onnipotente, Miike riprende la sua straniante discesa negli abissi della follia con la glacialità della pellicola. Arditi totali, scene esasperatamente lunghe, fotografia asettica sembrano far uscire questo prodotto dalla prima parte della sua filmografia. Alcune inquadrature poi denotano un uso della profondità di campo molto tecnico e assolutamente funzionale alla dilatazione tutta giapponese dei momenti di stasi. Gli inserti provocatori e quasi metacinematografici per la gratuità con cui sono inseriti nel contesto (ad esempio, la pioggia verde e le fiamme grossolane che incendiano i corpi) sorprendono in più parti senza mai ledere la sostanziale eleganza formale della serie. Perfino il livello dello splatter è mantenuto basso a vantaggio di un riuscito ibrido tra detection, richiami a un soprannaturale psicologico e riuscite caratterizzazioni dei personaggi.
MPD Psycho è diviso di due tronconi abbastanza netti. Nella prima parte, la più riuscita, il virus personalistico di Nishizono si trasmette per semplice contatto (indicato visivamente da un inserto anime stilisticamente démodé) a varie persone che, una volta infettate, commettono strambi ed efferati omicidi. Questa è l’occasione per Miike di fare denuncia verso i suoi amati/odiati concittadini, tutti assassini in fieri a cui basta solo una scintilla per accendere il loro fuoco violento. Nella seconda parte, invece, il regista di Osaka imbastisce una macrostoria con echi distopici che, pur continuando a produrre sana inquietudine (la quinta puntata con la reclusione di Nishizono all’interno dell’ospedale), smarrisce il fascino di singoli frammenti di follia a favore di un più comprensibile piano complottistico che coinvolge più generazioni. Il discrimine tra cinema e TV sta forse proprio in questo: che il primo si può permettere soltanto di suggerire visto i suoi tempi ridotti, il secondo vuole necessariamente spiegare. Ancora una volta, io mi tengo l’arte che indica col dito la luna.